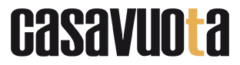Piccola introduzione a una pedagogia del corpo
 Il lavoro di formazione che propongo unisce forti suggestioni di contenuto verbale (brevi frasi tratte da opere di mistiche e mistici) a un lungo lavoro successivo che quelle suggestioni interpreta e svolge. Il lavoro è prevalentemente fisico. Dal punto di vista di una definizione puramente catalogativa, la prassi espressiva reale dei corpi al lavoro, nei miei laboratori, si potrebbe definire un teatro-danza. Appena l’ho proposta tuttavia, questa definizione mi appare molto generica. Il corpo si muove, e si muove non secondo strategie feriali, di comunicazione realistica. Dunque, forse basterebbe dire: il corpo danza. Ma anche la danza, che ha un codice, è in realtà in molti casi un punto di arrivo che si fa, o che s’è già fatta, stile. Dunque nemmeno di questo si può ancora propriamente parlare. Sospendiamo per ora il tentativo di una definizione sintetica della nostra ricerca sul movimento e proviamo invece a delinearne alcune caratteristiche generali.
Il lavoro di formazione che propongo unisce forti suggestioni di contenuto verbale (brevi frasi tratte da opere di mistiche e mistici) a un lungo lavoro successivo che quelle suggestioni interpreta e svolge. Il lavoro è prevalentemente fisico. Dal punto di vista di una definizione puramente catalogativa, la prassi espressiva reale dei corpi al lavoro, nei miei laboratori, si potrebbe definire un teatro-danza. Appena l’ho proposta tuttavia, questa definizione mi appare molto generica. Il corpo si muove, e si muove non secondo strategie feriali, di comunicazione realistica. Dunque, forse basterebbe dire: il corpo danza. Ma anche la danza, che ha un codice, è in realtà in molti casi un punto di arrivo che si fa, o che s’è già fatta, stile. Dunque nemmeno di questo si può ancora propriamente parlare. Sospendiamo per ora il tentativo di una definizione sintetica della nostra ricerca sul movimento e proviamo invece a delinearne alcune caratteristiche generali.
Il lavoro tende, a grandi linee, a invertire la polarità energetica quotidiana che vede la parte alta del corpo gravata di una quantità di stimoli di ogni sorta. Per prima cosa dunque, attraverso una serie di esercizi, si riscalderà la parte bassa del corpo favorendo uno svuotamento di testa e tronco a favore di un’irrorazione e di una stimolazione delle anche, delle gambe e dei piedi. Poi toccherà alle braccia: in esercizi specifici si riattiveranno, contemporaneamente, i quattro arti: le due braccia (e mani) e le due gambe (e piedi), che cercheremo di chiamare in causa in modo che il tronco, negli spostamenti, sia un centro il più possibile inerte (o più propriamente: un centro appoggiato, sostenuto). Dopo questo lungo riscaldamento muscolare sposteremo l’attenzione sul piano osseo. Come dico ora: le ossa sono il vostro coreografo. Attraverso varie visualizzazioni stimoleremo un esordio del movimento a partire da punti specifici d’articolazione, corrispondenti a altrettante giunture osteoarticolari.
Questo momento propedeutico, questo riscaldamento, se volete, non è null’altro che una proposta minima di attivazione del nostro aggregato, un esordio di movimento profondo, sul quale poi costruire un percorso il più possibile personale, legato alla qualità dell’attenzione propriocettiva di ognuna e ognuno. Per favorire ulteriormente questo percorso, oltre a indicazioni puramente fisiche, entreranno anche stimolazioni verbali.
Brandelli di resoconti d’esperienza mistica come la frase l’anima nuota nel mare della gioia di Marguerite Porete assomigliano a immagini come quella di Kazuo Ohno quando propone di improvvisare sulla frase l’anima cola giù, l’anima imbeve la terra. Sono suggestioni di questo tipo, koan sintetici da interpretare fisicamente, che proseguono le proposte iniziali di tipo meramente fisico.
Io ultimamente accompagno la ricerca delle allieve e degli allievi dipingendo con rudi pennelli da imbianchino alcune di queste frasi o altre, ancora più sintetiche, sopra grandi fogli di carta da pacco, assieme a alcune immagini, disegni, simboli, la cui importanza, o allusività, emergono naturalmente dal lavoro. In poco tempo la sala prove si riempie di questi cartelli/segnaletica a cui si può, se si vuole, ritornare al bisogno.
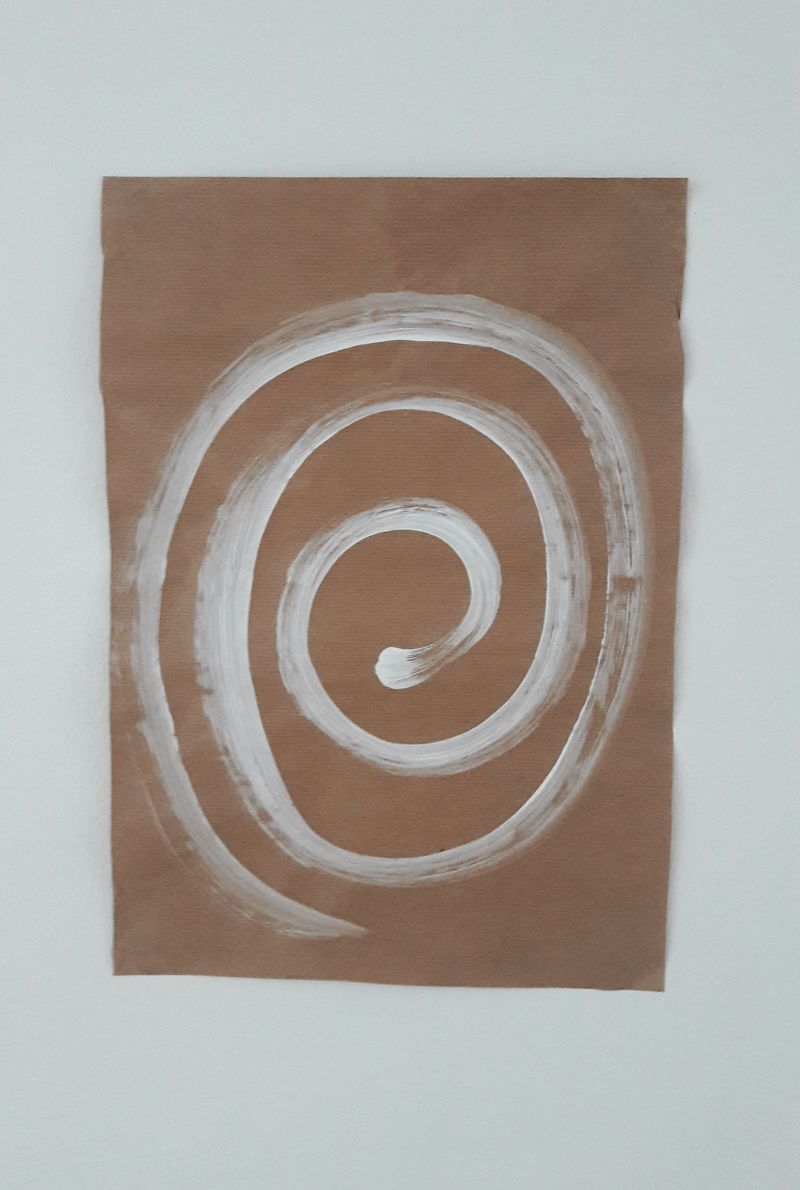 A seconda della via che l’allieva/o prenderà, la mia funzione sarà quella, sperabilmente maieutica, di verificare assieme a lei/lui la veracità della sua presenza nel tempo e nello spazio, di volta in volta stimolando discretamente l’ipomobilità esasperata frutto di un blocco, o richiamando un’ iperespressività a momenti di ulteriore ricentratura e propriocezione. Il fine di questo lavoro non è il raggiungimento di uno stile uniforme ma, al contrario, la ricerca di un’azione verace del corpo in questione, azione quindi unica e personale. Paradossalmente, questo lavoro può anche essere visto come una propedeutica alla codificazione, invece che (o oltre che) un punto d’arrivo espressivo di corpi già abituati a un codice fisico.
A seconda della via che l’allieva/o prenderà, la mia funzione sarà quella, sperabilmente maieutica, di verificare assieme a lei/lui la veracità della sua presenza nel tempo e nello spazio, di volta in volta stimolando discretamente l’ipomobilità esasperata frutto di un blocco, o richiamando un’ iperespressività a momenti di ulteriore ricentratura e propriocezione. Il fine di questo lavoro non è il raggiungimento di uno stile uniforme ma, al contrario, la ricerca di un’azione verace del corpo in questione, azione quindi unica e personale. Paradossalmente, questo lavoro può anche essere visto come una propedeutica alla codificazione, invece che (o oltre che) un punto d’arrivo espressivo di corpi già abituati a un codice fisico.
In ogni caso, l’elemento fondante riguarda il nuovo che ancora può emergere all’interno dell’abitudine fisica. Per fare spazio a questo nuovo, cioè a quanto di non usato c’è ancora in noi, schiacciato da tutto l’abusato che lo fascia, occorre molta pazienza, attenzione, e fiducia nel vuoto, nel sunyata, luogo fondante di molta arte e spiritualità orientali. Che il nuovo si trovi a partire da un vuoto è intuitivo. Cercheremo di capire quali sono le condizioni, per ognuna e per ognuno diverse, nelle quali questo vuoto propriamente ha luogo, può aver luogo. L’accadere di questi momenti di vacuità è invariabile, indipendentemente dal livello di coscienza e esperienza delle persone che intraprendono il lavoro. La radicalità, a cui le frasi e le immagini verbali che usiamo nel lavoro allude, serve proprio a delocalizzarci dalla nostra immagine feriale, conosciuta, mettendoci immediatamente in un terreno altro d’esperienza, un terreno deliberatamente esagerato, in cui la realtà viene, per così dire, ipergustata, chiedendoci così di tradurre in un segno fisico credibile questo brandello di unione, di più o meno fugace intuizione vitale.
Come si sarà forse evinto, il mio lavoro è su un soggetto singolo alla volta, sul suo percorso espressivo, ma direi meglio: de-espressivo, di svuotamento kenotico e deliberato. Tuttavia, proprio per questa centratura sul corpo singolo, il gruppo risulta fondamentale a equilibrare il lavoro, a renderlo possibile, ad assorbire i momenti di stanchezza. Una parte importante del lavoro riguarda un’educazione allo sguardo dei tentativi altrui. Si deve imparare non il giudizio del limite ma l’intuizione di quale possa essere il passo successivo, per uscire dal limite. Questo s’impara guardando gli altri, poi trasferendo questo sguardo su di sé. In fondo, quello che ci aiutiamo a fare, è frantumare il dolore danzandolo, secondo la definizione di Roberta Carreri. Quando questo livello di frantumazione ha raggiunto una certa dose di pervasività possiamo forse diventare anche oggetto di sguardo per qualcun’altro. Ma il lavoro in sala prove non arriva fin qua, perché concepire il piano performativo non come qualcosa di diverso dalla piena presenza ma come il semplice spiare la piena presenza di qualcuno da parte di qualcun’altro, tutto questo richiede molti anni di lavoro, e non solo in sala prove.
Alessandro Berti