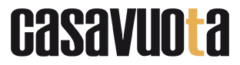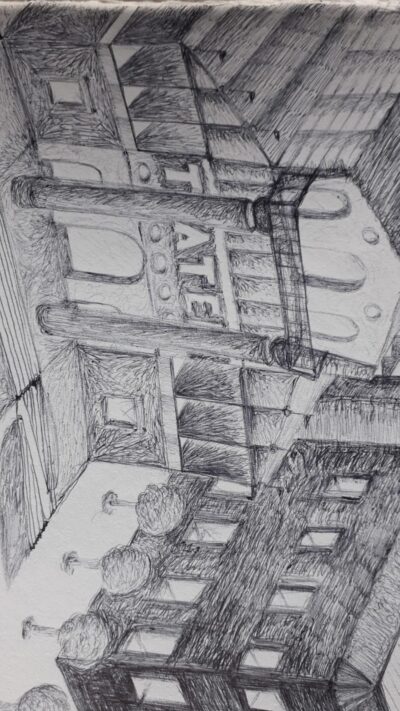Beatitudine
È giusto che lo spettatore sia vorace, voglia tutto per sé, sia geloso. E non consigli un libro bello, uno spettacolo. Anzi: mantenga il segreto, lo accarezzi, quel libro bello, lo ricordi in silenzio, quello spettacolo prezioso, sorprendente. Così si crea legame, nel mistero, tra intrattabilità su sponde opposte: quella di chi l’ha scritto, quel libro, e chi lo legge. Quella di chi l’ha concepito, lo spettacolo, e chi, nel buio della sala, l’ha guardato e ascoltato.
Per permettere questo, però, ci vorrebbero funzionari illuminati, intrattabili anche loro. E funzionarie streghesche, geniali. Cioè proprio un blocco di potere che il potere, la bestia che sfigura, lo sappia usare con distacco superbo, in quel modo aristocratico, assurdo, di chi mette la propria felicità sempre un po’ oltre, sempre un poco al-di-là. Ne ho conosciuti, di soggetti così. Gente burbera che pagava per tempo.
La massa bela, conforme, e il funzionario illuminato se ne frega, ne ha mandato. Coperto da un consenso su altri piani: sanità, imprese e il bla-bla-bla che sappiamo. Qui comandano i capi, e i pensionati esultano, in soggiorno. Ma è nell’educazione-a-immaginare, terra che più periferica non c’è, per chi comanda, che servono coraggio e sì, disprezzo: per la medìetas, per correttezze e centrismi. E per l’istinto gregario, che andrebbe ucciso sul nascere, subito, prima che esiga censure e autocensure. Trionfi qui il gioco e chi riesce a giocare. Trionfi la libertà, almeno qui, tra i contuncazzo beati.