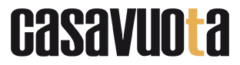Premessa utile: di questi tempi ci viene chiesto di parlare, ma non sappiamo esattamente cosa dire. Buttiamo giù qualcosa, che gli eventi poi superano. Allora riscriviamo. E ristracciamo. Però poi sembra brutto non rispondere. Qualcuno vuole sapere che pensi. Allora diamo per buona la terza, la quarta stesura. Ma non dobbiamo rileggerla troppe volte, sennò siamo tentati di non spedirla. Lo scritto che segue non fa eccezione.
Appunti di fine Olocene
Passerà. Qualcuno si avvicinerà alle estremità, dopo una vita di agi, di finte. Di quanto si avvicinerà e a quale estremo? Non sappiamo. Il cervello è però abbastanza neuroplastico. Cambieranno i rapporti, si dice. Probabile. Ho avuto la mia educazione sessuale ai tempi dell’AIDS. La cosa, in effetti, ha influito. Ma non dovremmo credere troppo alle lamentele, prima di tutto alle nostre (anche se ci abbiamo costruito su uno stile).
La pandemia è l’ouverture del collasso (o per chi da trent’anni si sgola: il primo tempo), quindi cosa chiediamo agli umani? Congiunti o meno, politici, artisti, che siano? Probabilmente non c’è niente da chiedere. Solo adeguarsi in tempo a quel che viene. E farlo insieme, il più possibile. Per ora, almeno: condividere le informazioni a riguardo. Stiamo uscendo dall’Olocene, sarà dura.
Non mi stupisco di non contare un bel niente. Chi è libero non conta niente, se si può lo si schiaccia, se non si può lo si ignora, lo si lascia morire. Spero che almeno cali un po’il numero di cortigiani.
Potremmo però fare qualcosa di politico. Bruno Latour, educatamente, lo propone (ma lui li chiama cahier des doleances, che non mi piace, anche se nel 1789 han funzionato): una specie di costituente bottom-up. Contribuirò.
È più probabile però, e pertinente alla sfera animale, che serva fare qualcosa off-line, nel nostro piccolo, nella sfera del lavoro, della pratica, quando potremo riaprire le porte. Che cosa?
Quello che sta funzionando, per ora, è una certa pazienza, unita alla qualità weiliana per eccellenza: l’attenzione.
La sanità che ha tenuto è territoriale, pubblica ma non ospedaliera (curare a casa, fare controlli, essere agili, veloci alla risposta). Strategia minoritaria ma efficace. Il sogno di un servizio pubblico non burocratico. Mi chiedo: come sarebbe l’equivalente, nel mio campo? Come sarebbe una cultura, pubblica, del genere?
Chissà. Ne tento a spanne una genealogia, naturalmente del tutto idealizzata.
A parte proprio la Pianura Padana, dove ancora si fronteggiano ad armi impari, nel resto d’Italia né il Capitale né il Comunismo hanno attecchito, anche solo per motivi orografici. Quando la strada comincia a salire, tutto cambia. Funzionerebbe invece meglio l’anarchismo: quello comunitario, mutualistico, di Kropotkin, di Ward, di Gary Snyder. E il cristianesimo paganeggiante degli Appennini. Senza sbancare montagne, si potrebbe vivere in scala ragionevole, producendo, senza zonizzazioni e grandi imprese, con un complesso più bilanciato di tutto (che è il contrario della paranoia dei nimby: ci sarebbero campi ma anche fabbriche, discariche, officine, non è un eden ma una mitigazione controllata, concertata, convinta, della pressione antropica sul mondo…).
In un modello sociale del genere, in nessun modo castale, la cultura, staccata dal resto, non può vivere. Né il resto senza, però. Naturalmente l’artista sarebbe in guerra con il resto anche qui. Ma le dinamiche sarebbero più rozze, più chiare. E l’abitudine alla prossimità più disponibile, più dell’ipocrita anonimato borghese, a tollerare, se non a digerire, le minoranze. Se invece saremo costretti alle sagre, come nella metropoli ai bandi e al precariato, o alle prediche di preti pedanti, come nella metropoli ai ghetti, allora possiamo sempre isolarci, creare e stare in pace. Produrre bene per poi esportarlo. Per poter dire quello che penso mi farò un orto (anche solo in effigie), così nessuno potrà ricattarmi. È l’ipotesi dei saggi taoisti, che i Re venivano umilmente a interrogare. E’ un immagine provinciale, antiquata, mi rendo conto. Ma chissà non ritorni moderna. La maggioranza, in sé, è un corpo crudele, andrebbe sempre smembrato. Quindi propongo smembramenti programmati, società complesse però in forma bonsai, insomma il meglio del Made in Italy da sempre, probabilmente.
Anche perché, in ogni caso, per sfregamento col Capitale ci si corrompe: la cosiddetta cultura si sfigura, e il massimo che riusciamo a fare, per un po’, è giusto resistere.
Lo si capisce bene in questi giorni, spariti i turisti americani, cinesi. Tutti a dire: ah, cazzo, la cultura allora non è solo turismo, cazzo, sì, è produzione, deve tornare di nuovo produzione! Con scuole, monumenti, alberghi chiusi, anche le menti meno sottili lo capiscono. Produrre frutta e verdura, produrre mascherine, produrre ventilatori polmonari, produrre spettacoli. Come nel sussidiario elementare: primario, secondario, terziario.
Invece per vent’anni, a sinistra, tutti a sognare la Disneyland della Cultura (Italia parco tematico a cielo aperto). E ora, finalmente, di nuovo: produrre. L’economia di guerra di queste settimane mostra che abbiamo ancora un tessuto manufatturiero.
Ne abbiamo uno anche artistico, culturale.
Ma adesso si dovrebbe produrre (e coltivare, e commerciare) in modo diverso.
Primo: a partire dai beni essenziali (il momento ci fa capire quali sono: sanità, istruzione, cultura e agricoltura…ci ricorderemo?). Secondo: a filiera corta e carbon free. Terzo: senza assembramenti di capitale, cioè difendendo la piccola impresa (fuck the Trust!).
Per me, sarebbero tutte garanzie di libertà. E quindi, in particolare per la cultura, di qualità.
Che bello se tutto il teatro andasse all’aperto (direttori artistici, iniziate i sopralluoghi!). Il teatro fatto all’aperto è un’altra cosa, lo sappiamo, dal teatro in interno. Cambia la voce, il corpo, cambia tutto. Col climate change (anzi, pardon: collapse), in Italia si può ormai stare fuori fino a Natale. (Invece sogniamo inverni post-brechtiani, di teatri con metà posti, di cloroformio, di congiunti in palchetto…).
Che bello se la scuola riprendesse, anche lei, solo all’aperto (maestri, tirate fuori l’erbario!)… Se le maestre, lettrici di Benjamin, portassero per le città le scolaresche, in una stagione di educazione incidentale, di faccia a faccia con la realtà, via dalle aule. (Invece si pensa a metà tempo in classe, mascherati, e metà in streaming…).
Che bello se approfittando della crisi del turismo, i sindaci facessero un calmiere degli affitti, e le città ritornassero reali (ultimamente anche a Bologna si trova casa).
Insomma il mio è un augurio illichiano, anche ora, anzi ora in particolare, ora che forse fatichiamo a discernere, oscillando tra nichilismo e rivoluzione, idealizzazione e rifiuto, teorie del complotto e abbandono alla divina virologia:
1. descolarizzare ma educare (ora si è obbligati, proviamoci)!
2. Demedicalizzare ma curare (finché e dove si può e in buona parte si può)!
3. E se cultura è animazione turistica, volontariato, entertainment in streaming (o tartufesco paracomunismo in extremis dei Grandi Capi che sentono aria di ghigliottina) allora: deculturalizzare!
Alessandro Berti
aprile 2020
www.ubuperfq.it/fq/index.php/it/eventi/pan-ubu/alessandro-berti